Ripubblico gli appunti che scrissi nel 1996 sulle condizioni
della Fortezza di Verrua Savoia, ossia prima del parziale restauro avvenuto tra
il 2012 ed il 2014: chi vuole potrà così vedere com’era “il Castello”
durante gli ultimi anni del secolo scorso, farsi un’idea su cosa è stato fatto e
su quanto c’è ancora da fare per arrivare – nei limiti del possibile – al
completo recupero di questo importante e bellissimo sito di interesse storico.
Con l’ausilio di questi appunti, nel 1997 vennero effettuate due visite guidate alla Fortezza: la prima promossa dell’Associazione Nòste Rèis, la seconda organizzata dall’ Associazione Amici del Museo Pietro Micca. In entrambe le occasioni ci fu un incontro con l’allora Sindaco di Verrua, Giuseppe Valesio, che accolse i partecipanti presso il Municipio per un saluto a nome del Comune.
Il buon successo delle
due predette iniziative (alle quali parteciparono rispettivamente 90 e 120
persone all'incirca) convinse il Sindaco Valesio ad iniziare un proficuo
percorso di riscoperta e rivalutazione della Fortezza che, in quei tempi, era
invece comunemente data come irrimediabilmente perduta.
Gli appunti del 1996 sono stati ora integrati, nella versione on-line, con:
-
una pianta dell’assedio del 1625;
-
alcuni fermo immagine della breve sequenza girata alla Fortezza per il film “Guerra e Pace”, le cui riprese avvennero nel 1955 nella stessa zona interessata dal successivo tragico crollo del 1957.
Auguro una buona lettura a tutti coloro che vorranno dedicarvi del tempo.


VERRUA SAVOIA
Una fortezza da salvare
appunti a cura di
Maurizio Gasparello
II
stesura: dicembre 1996
Sommario
Prefazione
LA FORTEZZA DI VERRUA, PROBLEMI DI TUTELA
A
Parte 1 - RIFERIMENTI
STORICI
CRONOLOGIA ESSENZIALE
Parte 2 - LA FRANA DEL
1957
FRAMMENTI DI CRONACA
Parte
3 - LA ROCCA OGGI
1) CAMMINANDO TRA I RUDERI
2) LA CONVENZIONE DEL 1989
Parte 4 - LA COLLINA
DELLA FORTEZZA
UN SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
Parte 5 - MOMENTI CINEMATOGRAFICI (aggiunta del 2022)
LE RIPRESE DI "GUERRA E PACE" DEL 1955
indice delle figure
Figura 1 - 1617: Anonimo, PIANTA DELLA FORTEZZA DI VERRUA
Figura 1bis - 1625: Anonimo, PIANTA DELL'ASSEDIO DEL 1625 (aggiunta nel 2022)
Figura 2 - ca. 1651: Carlo MORELLO, PLANIMETRIA DELLA FORTEZZA
Figura 3 - 1653: Carlo MORELLO, PLANIMETRIA DELLA FORTEZZA
Figura 4 - ca. 1680: Anonimo, PLANIMETRIA DELLA FORTEZZA
Figura 5 - ca. 1680: Anonimo, VEDUTA PROSPETTICA DELLA FORTEZZA
Figura 6 - 1704: Anonimo, PLANIMETRIA DELLA FORTEZZA
Figura 7 - 1704: Anonimo, PIANTA DELLA FORTEZZA
Figura 8 - 1780: Ignazio SCLOPIS, VEDUTA DELLE COLLINE CON LA ROCCA DI VERRUA
Figura 9 - 1818-1830: Pietro Giuseppe BAGETTI, L’ASSEDIO DI VERRUA
Figura 10 - ca. 1785: Pietro Maria CANTOREGIO, PIANTA DEL FORTE
Figura 11 - ca. 1785: Pietro Maria CANTOREGIO, PROSPETTO DELLA FORTEZZA
Figura 12 - ca. 1785: Pietro Maria CANTOREGIO: SEZIONE DEL FORTE
Figura 13 - ca. 1801: CLARDIVY: PIANTA DELLA FORTEZZA
Figura 14 - 1840: Clemente ROVERE: VEDUTA DELLA FORTEZZA
Figura 15 - STAMPA SERA del 5-6 Settembre 1957: FRANA LA ROCCA DI VERRUA
Figura 16 - STAMPA SERA del 6-7 Settembre 1957: SALTANO CON L’ESPLOSIVO I MACIGNI PERICOLANTI
Figura 17 - LA STAMPA del 6 Settembre 1957: VEDUTA AEREA DELLA FRANA
Figura 18 - LA STAMPA del 7 Settembre 1957: POSA DELLE MINE SOTTO I MASSI PERICOLANTI
Figura 19 - LA ROCCA PRIMA DELLA CAVA
Figura 20 - LA ROCCA PRIMA DELLA FRANA
Figura 21 - LA ROCCA DOPO LA FRANA
Figura 22 - PLANIMETRIA AGGIORNATA DELLA FORTEZZA
Figura 23 - SEZIONE AGGIORNATA DELLA FORTEZZA
Figura 24 - VIALE E DONGIONE
Figura 25 - DONGIONE E PORTA DI INGRESSO
Figura 26 - INGRESSO PRINCIPALE
Figura 27 - ABITAZIONE CUSTODE-GIARDINIERE
Figura 28 - CANTINE
Figura 29 - PASSAGGIO EX-PONTE LEVATOIO
Figura 30 - CISTERNE
Figura 31 - INGRESSO PASSAGGIO ALLA PORTA DI SOCCORSO CALCINA
Figura 32 - ABITAZIONE DEL MARCHESE
Figura 33 - INGRESSO ABITAZIONE DAL PIANO INFERIORE
Figura 34 - SERRA E VEDUTA PARZIALE DEL PIANO DONGIONE
Figura 35 - INTERNO ABITAZIONE DEL MARCHESE
Figura 36 - INTERNO ABITAZIONE DEL MARCHESE
Figura 37 - ZONA INGRESSO E DONGIONE
Figura 38 - INGRESSO DEL PONTE LEVATOIO
Figura 39 - PORTA DI SOCCORSO DETTA CALCINA
Figura 40 - FERITA NEI MURAGLIONI
Figura 41 - ZONA DELLA FRANA
Figura 42 - CAVA DI CEMENTO
Figura 43 - CAVA DI CEMENTO
Figura 44 - PONTE DI SOCCORSO
Figura 45 - LA STAMPA:
SPETTACOLI E MOSTRE, RINASCE LA FORTEZZA
Figura 46 -
GALLERIA CONTROMINA
Figura 47 -
FINE GALLERIA CONTROMINA
Figura 48 - POZZO
Figura 49 - GALLERIA
Figura 50 - GALLERIA
Prefazione
LA FORTEZZA DI VERRUA, PROBLEMI DI TUTELA[1]

Figura 1 - 1617: Anonimo, PIANTA DELLA FORTEZZA DI VERRUA.
Nella planimetria sono indicati
alcuni punti. Da sinistra:
1)bastione Forte; 2)Castello;
3)Fontana; 4)Posto da
fortificarsi; 5)Fortello;
6)Borgo.
E' estremamente
importante notare nella
zona del Fortello la presenza di
un grande edificio a tre navate
con abside (7),
certamente una
chiesa d’impianto basilicale
data la sua particolare
configurazione.
Posta nell’ansa che il Po forma di fronte alla pianura di Crescentino, la rocca
di Verrua si pone geograficamente a baluardo delle aree al di là dell’innesto
della Dora Baltea nel Po, costituendo quindi il primo e più importante baluardo
a difesa dell’area canavesana e Torinese verso la Pianura Padana. Ciò spiega
l’antichità del luogo menzionato fin dal X° sec. e comunque sempre presente
nelle cartografie della zona a partire dalla fine del ‘500. Sempre strenuamente
difesa, prima del ‘500 dai Vercellesi consapevoli dell’importanza del luogo, la
zona compare tra i luoghi fortificati significativi del ducato sabaudo nel
Theatrum Statum Regiae Celsitudinis Sabaudiae Ducis e nella stampa realizzata
dal De Vitt e pubblicata a Amsterdam a fine seicento (1670) dal Comitatum
Niceusem et coeteres partes minores con la sua triplice serie di mura. Quando il
vercellese perde definitivamente Verrua, dovrà rinforzare le fortificazioni di
Crescentino, come testimonia la carta del Belgrano del 1680 conservata alla
Biblioteca Reale di Torino. Il Theatrum ricorda l’importanza della zona, precisa
che essa era un tempo a forma triangolare e racchiudeva nella parte alta oltre
al forte il Palazzo del Governatore e la Chiesa di S. Giovanni Battista.
Possiamo dire che il complesso di Verrua è l’emblema delle difficoltà
amministrative che talvolta impediscono la tutela del territorio. Da anni viene
condotta una vera e propria battaglia amministrativa volta a impedire e fermare
l’attività estrattiva della zona senza esito, a causa delle vigenti disposizioni
in materia di cave, e ciò nonostante le rovinose frane avvenute nel 1957 e nel
1967. Ci si chiede quali rimedi porre a tale rovinosa e pur legittima attività
che porta gradualmente alla distruzione di un luogo di grandissimo interesse
storico e archeologico di grande rilevanza per la storia del territorio
piemontese. Devo rilevare che a fronte di situazioni così emblematiche risulta
evidente l’inadeguatezza di provvedimenti legislativi anche di vasta portata,
come la legge “Galasso”, mentre assai più efficace sarebbe risultato un
provvedimento e disposizioni che chiarissero che le attività estrattive non
possono configurarsi come attività senza ambiti precisi ma che devono trovare un
limite nel pubblico interesse, da quantificarsi anche tenendo conto dei costi
economici dei dissesti ecologici. Ogni azione di valorizzazione del territorio,
anche i pur preziosi studi storici essenziali per una corretta conoscenza dei
problemi, risulta inefficace se non si prevedono strutture tecniche adeguate che
possano di fatto esercitare una tutela oggi affidata, occorre precisarlo, a
venti giorni di istruttoria di pratiche presso gli uffici delle Soprintendenze
con un criterio che, per chi conosce veramente i problemi di tutela, non può che
ingenerare serie preoccupazioni per il futuro.
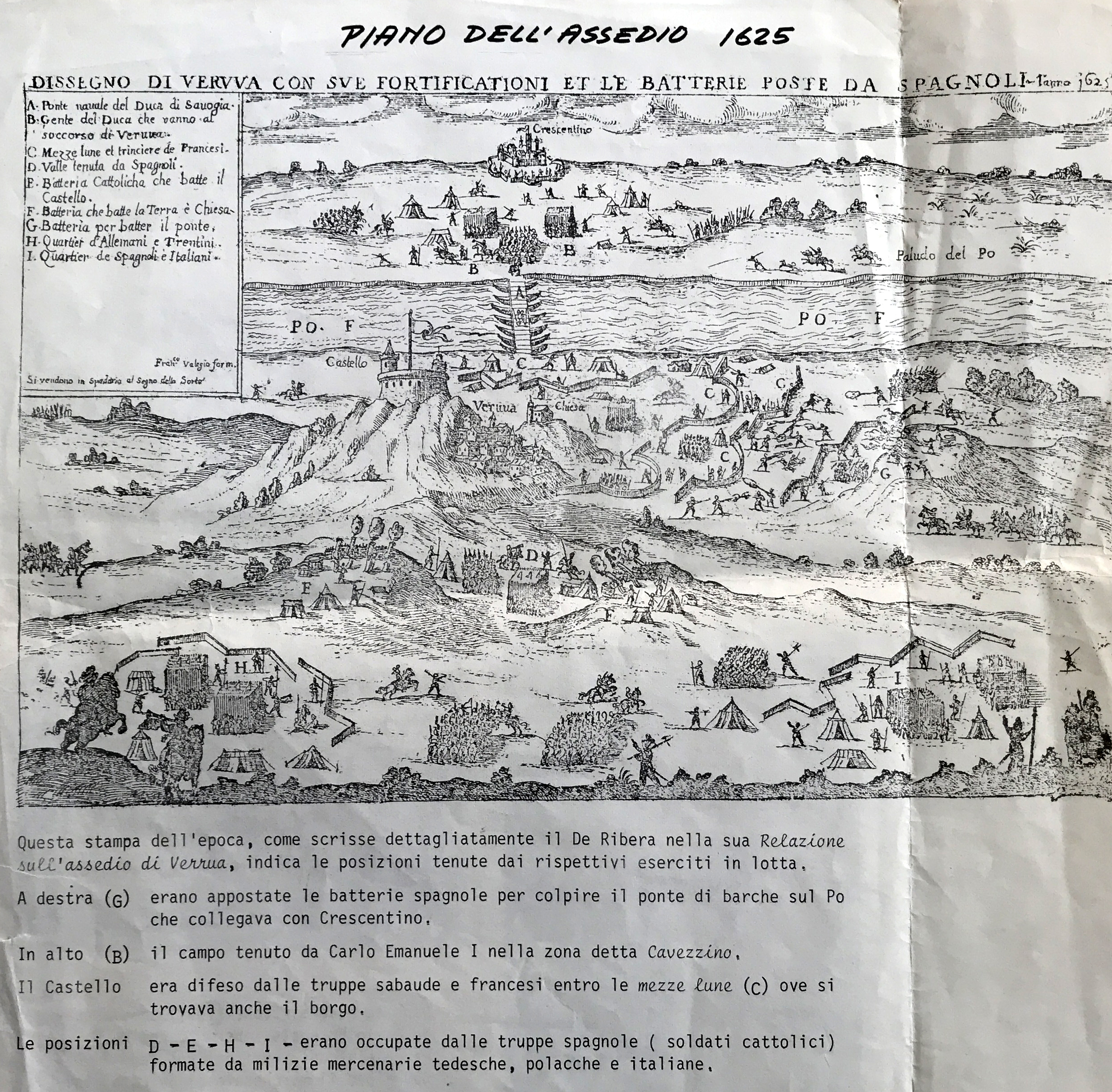
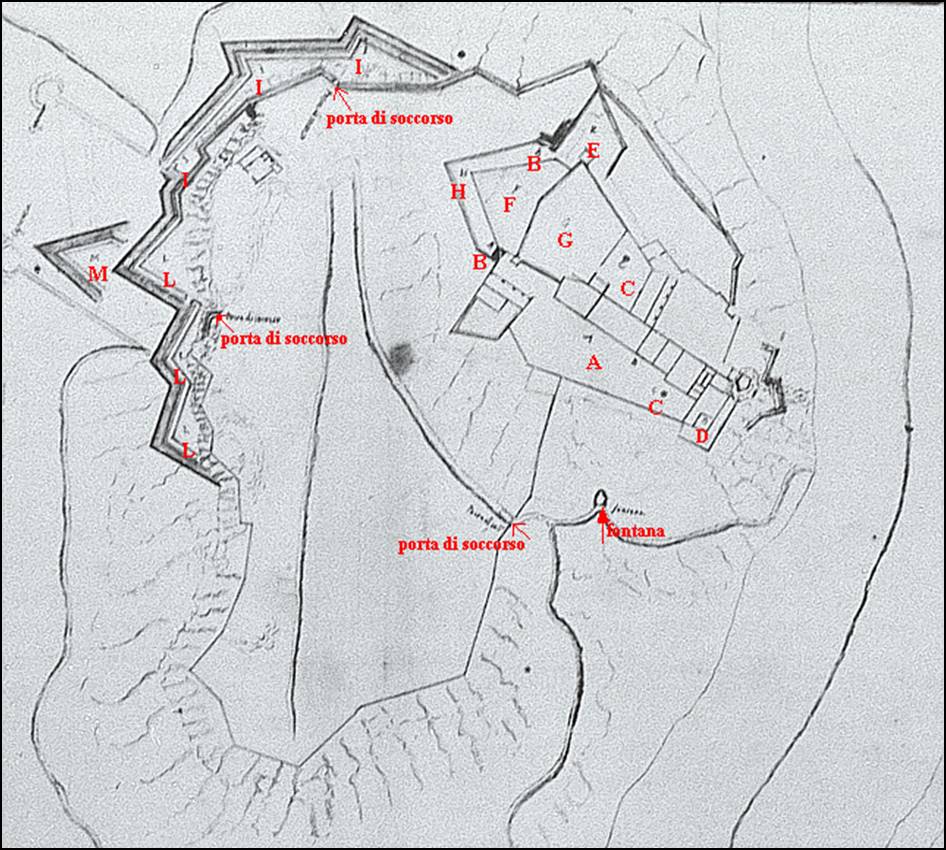
A.
Castello di Verua
B.
Porte del castello
C.
Sisterne, Alta è bassa
D.
Forno con su corte
E.
Bastione non finito
F.
Piataforma Alta non finita
G.
Piasseta piu alta della
piataforma segnata F e H falsa
braya dela deta piataforma
I. Falsa braya qual gia si ritrouaua fatta, non piu di altessa di 2. Piedi di riparo et hora si ritroua con fuosso largo: 2 tesse,
et una tessa di
profondo con la sua pallissatta
al fondo di detto fuosso,
deifessa dal di dentro
L. messaluna grande con doi altri trauagli assioli ene missino si possono meter à Coperto sotto il rocho, è li detti trauaglierono
ma tutti ruinati et ora sono
tutti in bona difessa con li soi
fossi rebassati e la sua
pallissata nel messo
M.
mesaluna picolla che era tutta
Ruinata et hora in bona difesa
Nella planimetria sono inoltre indicate due porte di socorso verso il giogo delle colline ed altra prossima ad una fontana nel versante del Po.
Si può
ritenere la planimetria un
rilievo sullo stato di
conservazione della fortezza,
eseguito a preparazione degli
interventi proposti nel disegno
successivo.
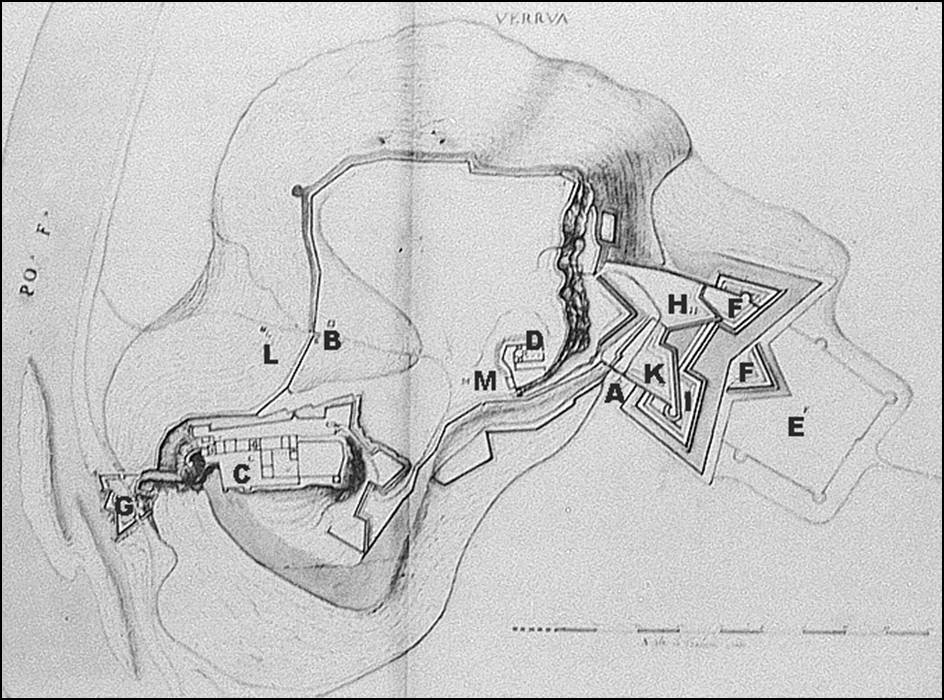
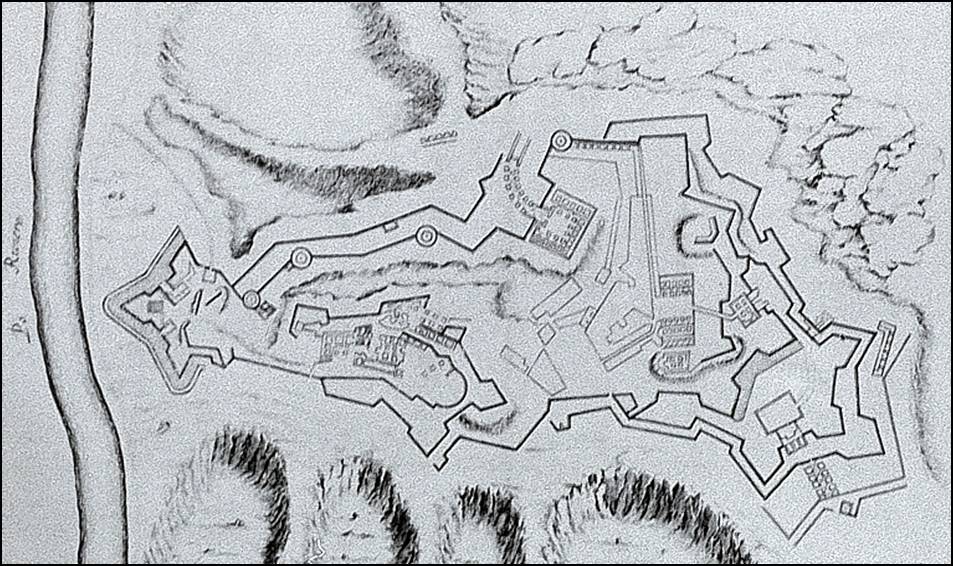
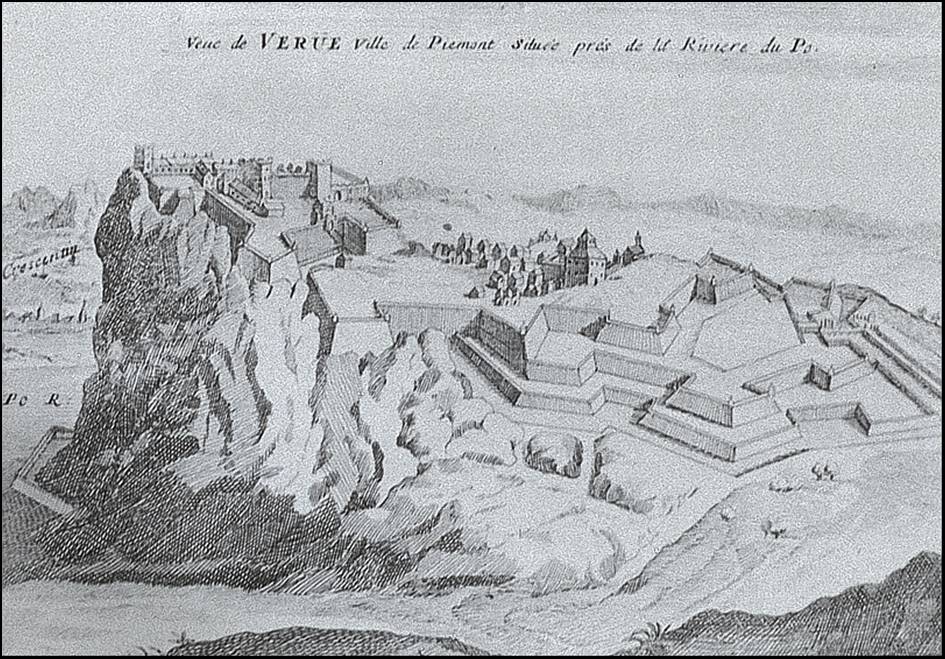
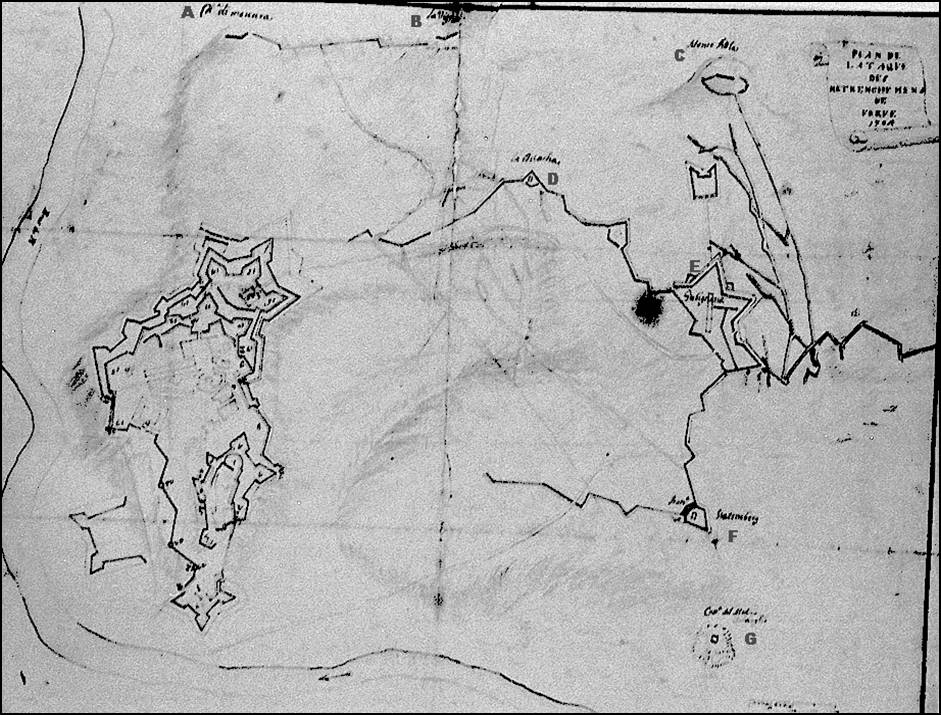
Figura 6 - 1704: Anonimo, PLANIMETRIA DELLA FORTEZZA.
|
?: |
L’origine militare della Rocca di Verrua è di
probabile epoca Romana (dal latino Verruca che,
per traslato, identificava un luogo aspro ed
elevato, importante militarmente). |
|
999: |
L’imperatore Ottone III emette un diploma a
favore del Vescovo di Vercelli, Leone, per la
Rocca di Verrua. |
|
1027: |
Corrado il Salico conferma il diploma a favore
dei Vescovi di Vercelli. |
|
1151: |
Il Barbarossa conferma il diploma a favore degli
stessi Vescovi. |
|
1167: |
Verrua viene assediata e distrutta, con grandi
stragi, ad opera del Barbarossa quando Pietro,
suo governatore, rifiuta di riconsegnare il
Castello. |
|
1191: |
L’imperatore Enrico VI lo restituisce al Vescovo
di Vercelli, Alberto; successivamente, il
Castello passa sotto i Marchesi del Monferrato. |
|
1244: |
L’imperatore Federico II toglie il Castello ai
Marchesi del Monferrato. |
|
1248: |
Federico II riassegna il Castello al Marchese
Bonifacio del Monferrato; successivamente, se ne
impadroniscono i Conti di Savoia. |
|
1294: |
Il Marchese Giovanni di Monferrato, pur di
riavere Verrua, restituisce al Conte di Savoia
molti paesi e castelli. |
|
1305: |
Verrua si sottomette di nuovo a casa Savoia,
prestando omaggio di fedeltà a Filippo. |
|
1311: |
Tornata sotto il controllo dei Vescovi di
Vercelli, Verrua si trova al centro di una
contesa tra gli Avogadro ed i Tizzoni, potenti
famiglie vercellesi. Il Vescovo Uberto Avogadro
fortifica la rocca di Verrua per difenderla dai
Tizzoni di Crescentino. |
|
1357: |
Dopo alterne vicende, il Vescovo di Vercelli
cede definitivamente il Castello ed il Feudo di
Verrua ad Amedeo VI di Savoia, il Conte Verde. |
|
1387: |
Verrua è difesa dalla popolazione contro
l’esercito del marchese Teodoro di Monferrato,
che si è accampato per assediarla, sulla riva
destra del Po: la resistenza permette al Conte
Rosso, Amedeo VII di Savoia, di portare la
guerra in Monferrato e quindi di costringere il
Marchese alla pace. |
|
1543: |
Verrua diventa feudo dell’importante casa
biellese degli Scaglia, nella persona di
Giovanni Bernardino, con il titolo di conti dal
6 luglio 1561. |
|
1625: |
dal 9 agosto al 17 novembre si svolge il più
fortunato e memorabile assedio, contro gli
Spagnoli, comandati dal governatore di Milano
Duca de Feria e dal capitano don Gonzalo de
Cordova, sconfitti dai Piemontesi e dagli
alleati Francesi. |
|
1704-1705: |
L’eroica e sfortunata resistenza di Verrua
nell’ultimo suo assedio permette a Vittorio
Amedeo II di giungere, nel 1706, alla vittoria
contro i Francesi nella Battaglia di Torino,
destinata a segnare le sorti della guerra e
dell’Europa insieme a quella della Dinastia, che
arriverà così alla corona reale di Sicilia prima
e di Sardegna poi. |
|
1785: |
Verrua ritorna sotto il diretto controllo dei
Savoia con la costituzione del Marchesato, il 3
giugno 1785. |
|
1955: |
Il Castello e la circostante collina vengono
ceduti dai Marchesi di Invrea ad un’impresa di
estrazione cementifera. Il Castello resta
abbandonato ad atti vandalici e sottrazioni di
ogni genere. |
|
1957: |
Crolla la parte del Castello situata nella zona
collinare presso il ponte sul Po: nello
smottamento precipitano a valle la famosa Rocca
e l’antica cappella. A causa del crollo, viene
interrotto il ponte sul Po e sepolta una vicina
casa, nella quale trovano la morte sette
persone: la strage resterà senza responsabili. |
|
1967: |
Una seconda frana interessa parte della collina
del Castello di Verrua, senza tuttavia
coinvolgere cose e persone. Nel frattempo, lo
scavo della cava di cemento ha portato alla
distruzione delle abitazioni esistenti sulla
collina, alla rimozione di numerose gallerie che
costellavano la collina intorno alla fortezza e
irrimediabilmente compromesso l’assetto
paesaggistico della zona. |
|
1989: |
La ditta Cementi Vittoria di Trino Vercellese,
proprietaria dell’antico Castello e dei terreni
circostanti, stipula una convenzione con il
sindaco di Verrua Angelo Arturo Castelli, con la
quale si impegna ad investire 100 milioni in
dieci anni per i lavori di rifacimento dei tetti
e dell’ingresso e per la rimozione degli stati
di pericolo tra le mura della fortezza. Come
contropartita il Comune autorizza la ditta
all’esercizio decennale di una cava di pietra
per cemento posta nelle vicinanze della
fortezza. L’autorizzazione è revocabile in caso
di inadempienza. Gli interventi risultano una
goccia nel mare del degrado e non raggiungono lo
scopo di preservare la fortezza, nonché di
rimuovere le situazioni di pericolo. |
|
1996: |
Vengono rubate le grondaie in rame disposte nel
1989 con il parziale rifacimento del tetto
mentre, in corrispondenza delle ferite aperte
nei muraglioni della vegetazione, si aprono
ulteriori brecce, dovute alla sottrazione, da
parte di ignoti, dei mattoni che costituiscono i
muraglioni stessi: l’antico Dongione, così come
il sottostante storico Ponte di Soccorso,
insidiato dalla vegetazione, corrono imminente
pericolo di crollo. Restano da verificare la
congruità della convenzione stabilita nel 1989
con l’impresa d’estrazione per la salvaguardia
della fortezza e i risultati ottenuti con gli
interventi comunque previsti. |
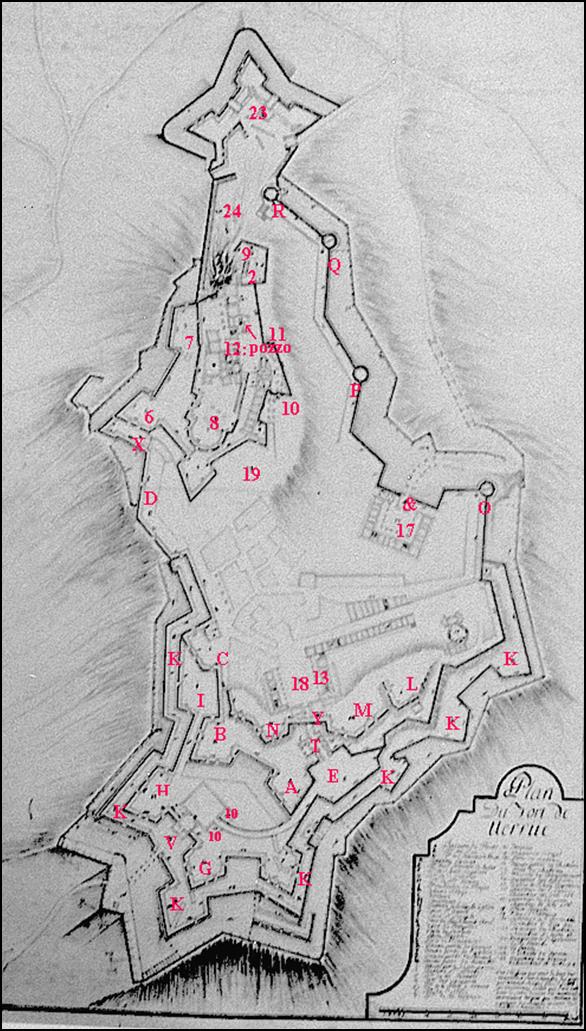
Figura 7 - 1704: Anonimo, PIANTA DELLA
FORTEZZA. Purtroppo, l’impossibilità
di prendere visione dell’originale a grandezza naturale non ci permette, per
ora, di evidenziare sulla pianta tutti i riferimenti riportati nella legenda:
A. Bastion du Prince; B. Bastion du Duc; C. B.n de S.t
Francois de Paule; D. Bastion Camus; E. B.n de S.t.
Francois de Sales; F. B.n de S.t Jean Baptiste; G. B.n
de S. Charles; H. B.n de S.te Marie; I. B.n du
Jardin du Maior; K. Fausse Braye; L. Torasse; M. Courtasse; N. Batterie de la
Vieille Eglise; O. Tour de S.t André; P. Tour de S.t
Joseph; Q. Tour du Bienhereux Amè; R. Tour du Precipice; S. Porte du Secours; T.
Porte Royale; V. porte del Auancée; X. Fausse porte du Camus; Y.Fausse porte del
Eglise; Z. Fausse porte du leuant; &. Fausse porte du moretti; 1. Fausse porte
du precipice; 2. Bastion S.te Barbe; 3. B.n dè la Terasse;
4. B.n des Sargents; 5. B.n de la Place d’armes; 6.B.n
de l’Alle; 7. B.n de la Uigne; 8. Donjeon; 9. Magasin Royal;
10. Porte du chateau; 11. Fausse porte du chateau; 12. Puis du chàteau; 13.
Maison du Gouuerneur; 14. Quartier des Officiers; 15. Eglise de S.t
Jean Baptiste; 16. Casermes dè l’Eglise; 17. Casermes du Secours - Chambres 38:
licts 166; 18. Place Royale; 19. Place d’Armes; 20. Casermes de l’Auancée -
Chambres 8: licts 32; 21.Casermes du Chateau - chambres 3: licts 17; 22.
Magasins à l’Epreuue de la Bombe; 23. Le fortin; 24. L’echelle du fortin; 25.
Quartier du Gierico - Chambres 11: licts 32; Les Chiffres qui sont le long de
murailles c’est le nombre de pas qui contient chaque flanchfaus ou courtines,
celles que l’on nas dans le fosse deuant les courtines marquent les pas que
contient le parapet du chemin couuert de chaque tenaille.
Il disegno è documento importantissimo
per la precisa descrizione di tutte le parti componenti la fortezza nella loro
esatta funzione. E’ definitivamente scomparsa la vecchia chiesa sulla cui area
sorge ora una batteria e la Piazza Reale. Una chiesa, di ridotte dimensioni e a
pianta centrale, dedicata a San Giovanni Battista, è stata costruita presso il
bastione di Levante. Si ha inoltre, per la prima volta, l’indicazione della
presenza del pozzo, ubicato in un ambiente interno al castello, in sostituzione
della cisterna esterna quasi antistante segnalata nella pianta del 1653 del
Morello. Opera di notevole valore ingegneristico è stato, purtroppo
recentemente, cancellato da un ingiustificato riempimento a seguito del crollo
di parte del colle avvenuto nel 1957. La comunicazione della Rocca con il
Fortino sottostante, presso la riva del Po, avveniva mediante una lunga scala,
segnata in pianta al n. 24. Scala che è ancora visibile in alcune vedute del
tardo Settecento. Per l’efficiente situazione raffigurata e descritta di tutte
le componenti della Fortezza, il disegno è da considerarsi eseguito poco prima
dell’assedio del 1704.
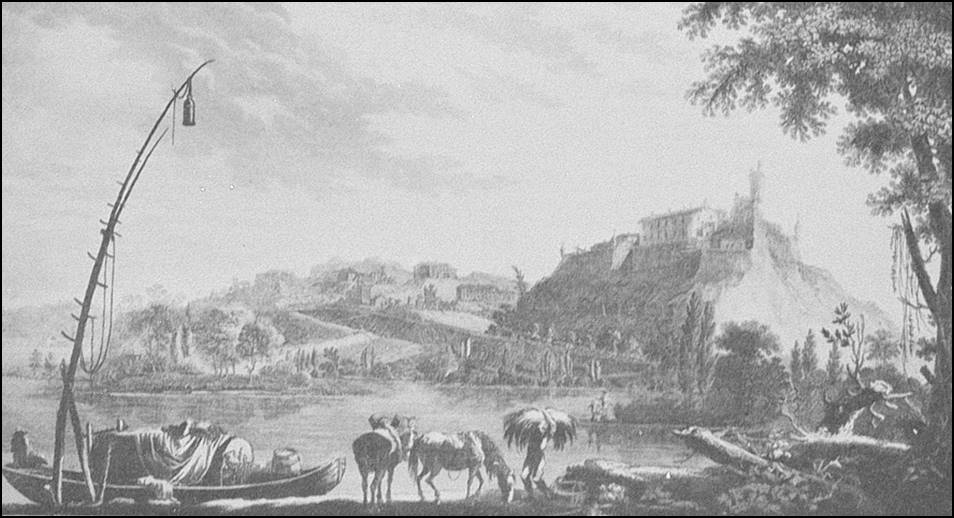
Vista dal versante di
Crescentino, si può scorgere il
passaggio sul ponte di soccorso.
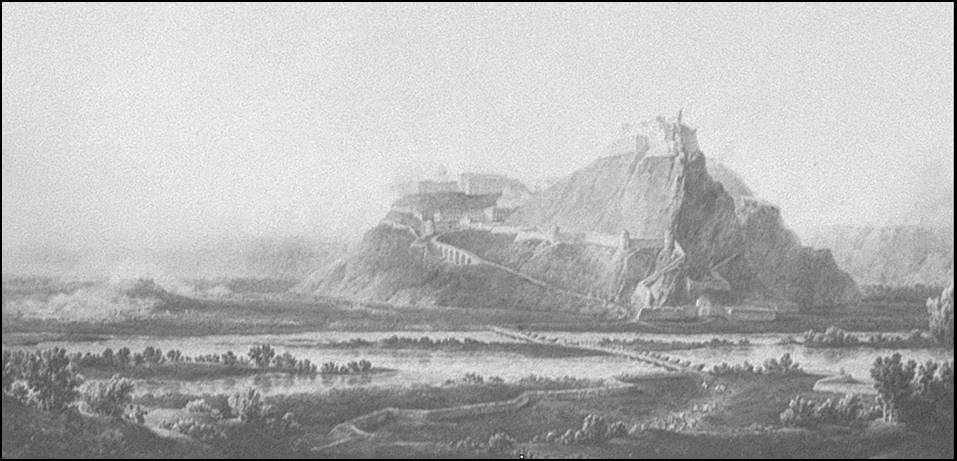
Figura 9 - 1818-1830: Pietro Giuseppe
BAGETTI,
L’ASSEDIO DI VERRUA.
Rappresentazione dell’assedio del 1705
dal lato Nord. La precisa collocazione del ponte di soccorso,
qui ben visibile, e uno dei pochi resti delle antiche
fortificazioni, è elemento inconfutabile per ritenere che l’artista si sia recato sul posto
prima dell’esecuzione del dipinto. L’acquerello fa parte di una
serie di trentaquattro dipinti di fatti d’arme eseguiti
dall’artista dal 1818 al 1830.
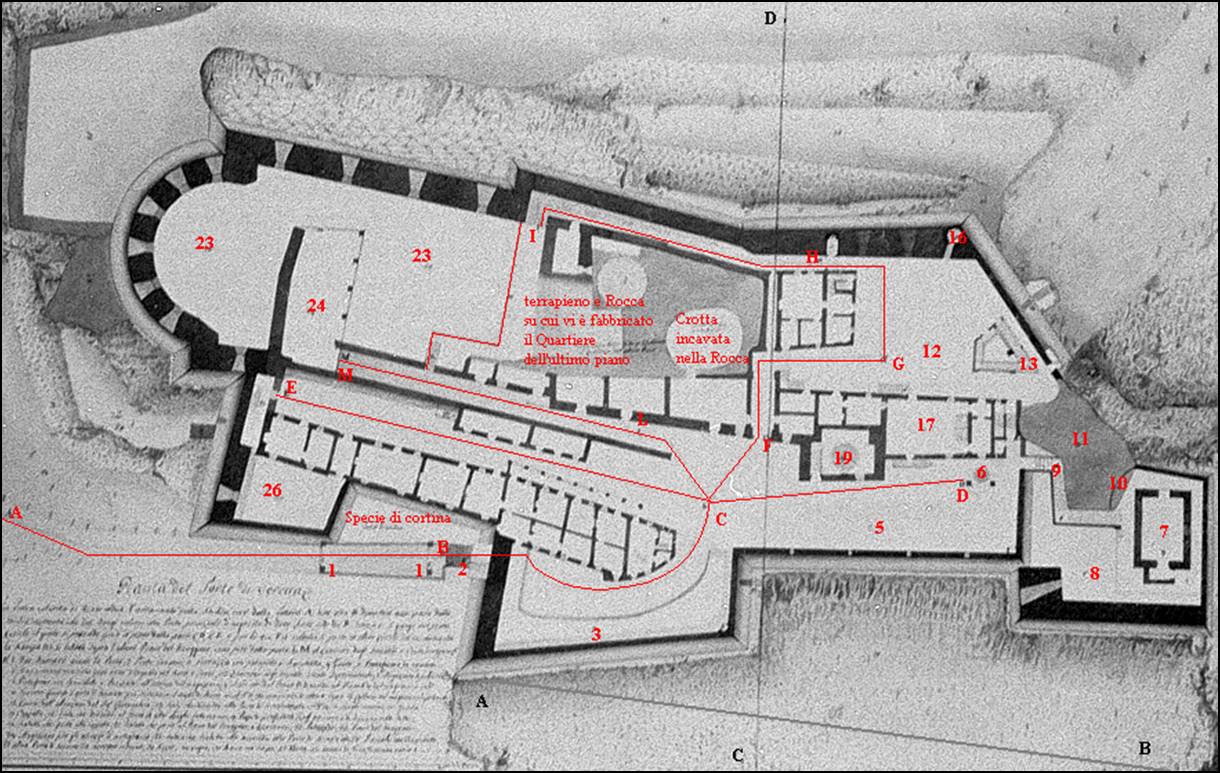
La pianta è stata eseguita certamente in
riferimento ai lavori di risistemazione dell’ormai sola Rocca per adibirla ad
ospitare gli Invalidi. Al centro presso il Terrapieno e Rocca su cui vi è
fabbricato il Quartiere dell’ultimo piano
è indicata la presenza di una Crotta incavata nella Rocca,
ed una Specie di cortina
è ricavata in prossimità dell’ingresso
principale con ponte levatoio. Il grande pozzo, incluso in un ambiente del
castello, continua ad essere elemento di rilievo nelle strutture. Anche la
cappella, costruitagli accanto, era quella ancor esistente prima del crollo del
1957. Merita a questo proposito il notare l’appunto a riguardo dello spuntone di
roccia (n. 11) già pericolante all’epoca del disegno, il cui crollo tuttavia
avvenne solo nel 1957, complice la noncuranza della delicata situazione
preesistente. E’ da rilevare inoltre il graduale mutamento dell’ambiente
circostante. Lungo i bastioni occidentali ha inizio infatti lo sfruttamento del
terreno adibito ora a coltivo anche con vigna.
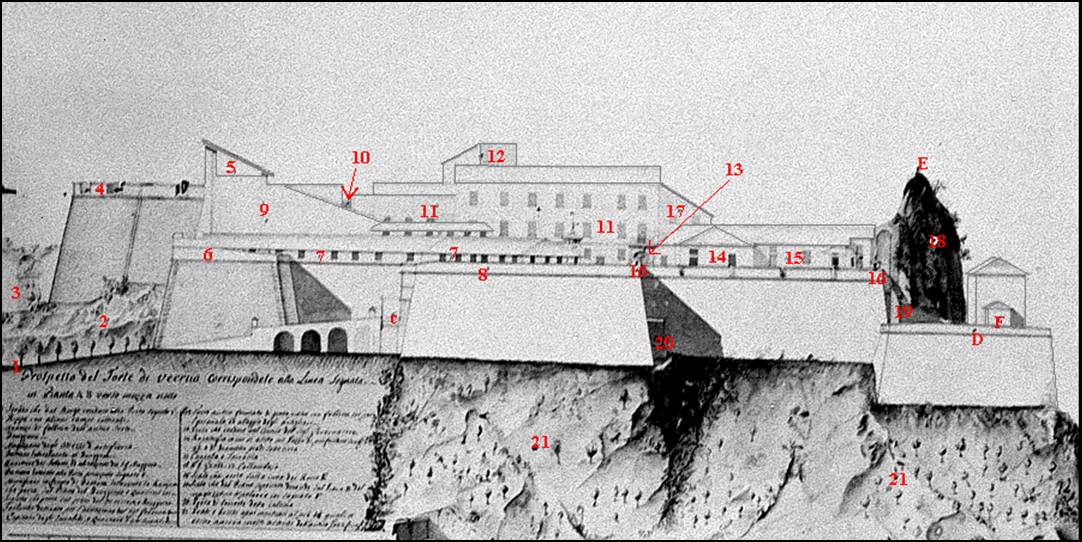
Il trabucco,
prima del 1818, è corrispondente a 3,082596 metri.
Il trabucco piemontese si divide in: 6 piedi, il piede in 12 once, l`oncia in 12
punti, il punto in 12 atomi.
Parti di trabucco piemontese:
1 piede è pari a 51,3766 centimetri.
1 oncia è pari a 4,2814 centimetri.
1 punto è pari a 3,568 millimetri.
1 atomo è pari a 0,297 millimetri.
Fonte:
http://www.verbanensia.org/metrologica_details.asp?metrID=39258#:~:text=Il%20trabucco%20%C3%A8%20qui%20ragguagliato,pari%20a%2051%2C3766%20centimetri.
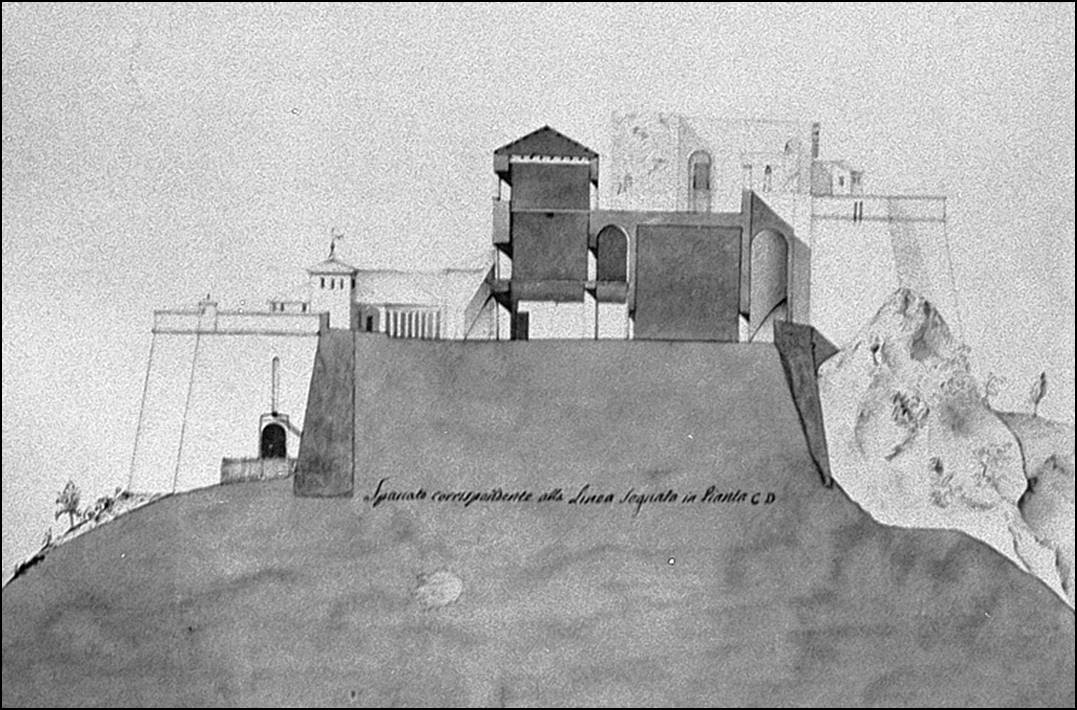
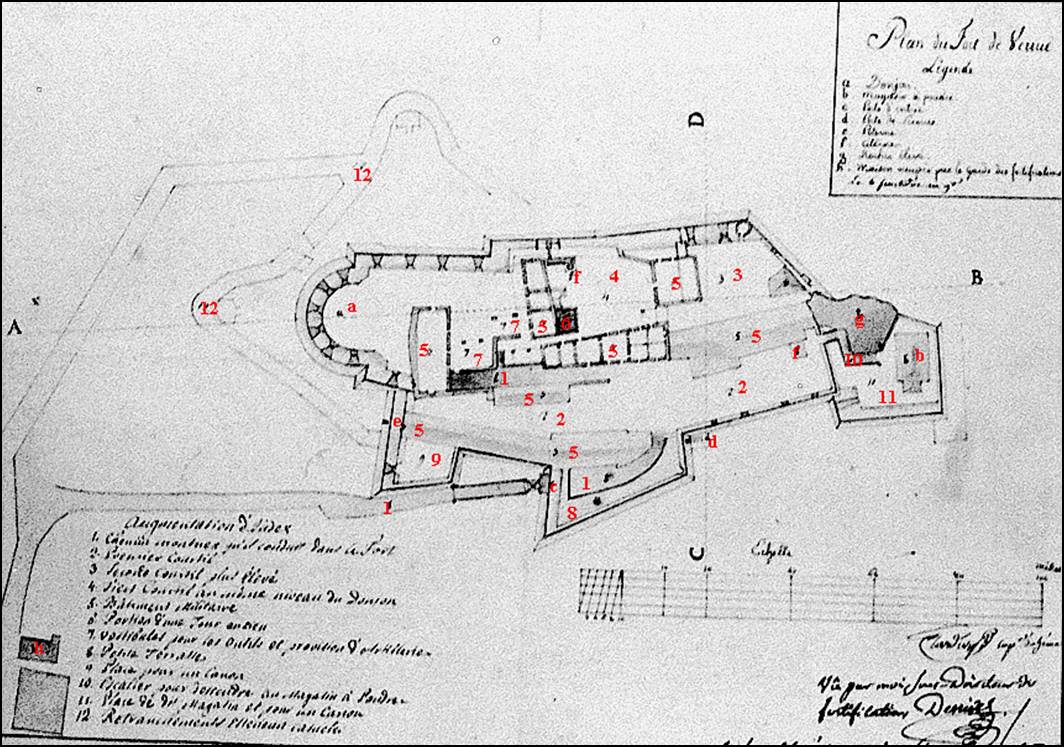
Si direbbe la pianta del piano superiore
della planimetria del Cantoregio.
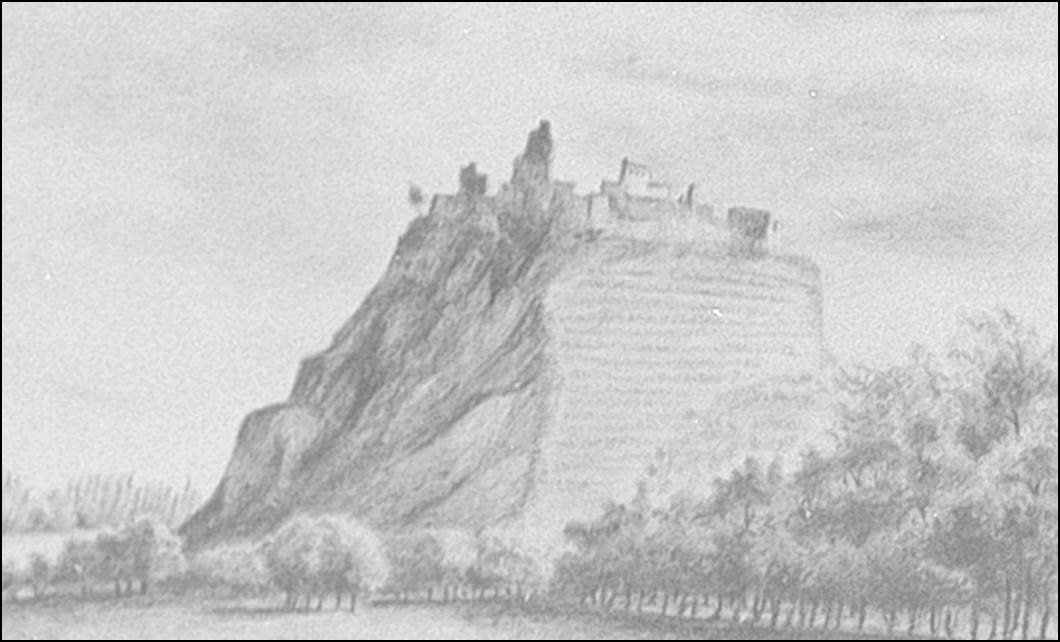
E’ interessante notare la coltura a
vigneto del versante Sud del colle, segno evidente dell’ormai cessata funzione
bellica del complesso.
Parte 2
LA FRANA DEL 1957
FRAMMENTI DI CRONACA
STAMPA SERA del 5-6 Settembre 1957.
CRESCENTINO, giov. sera. Una catastrofe è avvenuta questa mattina verso le ore 8
a Verrua Savoia, sulla sponda destra del Po, poco oltre Brusasco (circa 43
chilometri da Torino). Il fianco della collina ben conosciuta con il nome di “La
Rocca”, sulla quale si erge il famoso castello, è franato con orrendo fragore,
spazzando una casa in cui si trovavano 7 persone, coprendo la strada che porta a
Casale sotto uno strato di terriccio e massi alto una decina di metri, arrivando
fino a demolire ben tre arcate del ponte che attraversa il Po in direzione di
Crescentino. Delle sette persone sepolte, una soltanto, un bimbo di pochi anni,
ha potuto essere estratto ancora in vita, perché la rovina l’aveva spinto sotto
ad un’arcata del ponte e qui era stato protetto dai mobili della stanza da
letto, che il caso gli aveva ammassato intorno (...).
La catastrofe è avvenuta pochissimi secondi dopo le otto. Una donna del posto ne
è testimone: la trentacinquenne Paola Orsella. Passava lungo la strada che va a
Casale in bicicletta, udì distintamente un campanile rintoccare otto volte.
Percorse ancora pochi metri, poi dovette arrestarsi perché temeva di avere le
traveggole. La “rocca” che le stava di fronte non era più ferma come l’aveva
vista mille volte: si muoveva, aveva cominciato ad abbassarsi, ed intanto dalle
viscere della terra giungeva un rombo sordo ed allucinante, come se lontano
passasse un treno a pazza velocità.
(...) Tutta la montagna, alta quasi duecentocinquanta metri, che le stava
davanti, era in movimento. In alto si era aperta una crepa giallastra, il resto
slittava sempre più in fretta, sempre più in fretta, crollavano alberi, macigni
rotolavano lungo i fianchi... poi la polvere, una polvere rossastra, densa da
mozzare il fiato, sommerse tutto, in una visione apocalittica da cataclisma
universale.
(...) Dove prima era un declivio boscoso, ora il fianco si era spaccato in una
colossale fenditura giallastra, come uno scivolo immane. Unico intatto lassù
contro il cielo azzurro, era rimasto il vetusto castello, ma anch’esso sembrava
pencolare verso il vuoto. A quanto si è potuto constatare in seguito, la frana
si è iniziata a circa due metri di distanza dai muraglioni esterni;
probabilmente la stabilità della costruzione, risalente in gran parte al
dodicesimo secolo, è gravemente compromessa.
(...) Ed ora, non resta che cercare di indagare sulle cause che possono aver
provocato tanto disastro. Queste sembrano abbastanza chiare. Tutta la “rocca”
era traforata da gallerie, cunicoli di ogni dimensione e lunghezza, da parte di
imprese diverse che ne ricavavano materiale da cemento. A poco a poco la
collina, che già negli ultimi tempi aveva dato allarmanti segni di cedimento, si
è afflosciata, fino a slittare nella sua interezza.
Nei paesi vicini si dice che la montagnola in diversi punti aveva dovuto essere
fasciata da cavi d’acciaio perché non si sfasciasse; si aggiunge pure che un
sopralluogo recente ed ufficiale l’avrebbe dichiarata “non pericolante”: voci
che l’inchiesta confermerà o meno (...).
LA STAMPA: SPECCHIO DEI TEMPI.
Un lettore ci scrive:
“Mi riferisco al disastro successo a Verrua Savoia: come pescatore appassionato
sono stato sul posto molte volte, e pur essendo un incompetente in materia di
scavi, mi è sorto parecchie volte il dubbio che la collina su cui sorge il
castello non potesse resistere alle frequenti deflagrazioni provocate
dall’impresa addetta alle estrazioni di tufo.
Ciò che mi rimane incomprensibile è come - a poche decine di metri da un ponte
di grande importanza, all’incrocio di tre vie, ed in prossimità dell’abitato -
si potessero effettuare tali escavazioni a mezzo di materiale esplosivo. Ricordo
infatti che, in una sola mattinata, il traffico fu interrotto per ben 6-7 volte.
E l’intendenza alle Belle Arti, sicura tutrice del noto castello, non ha pensato
mai di porre termine ai lavori sottostanti?”
Carlo Pagliero - Torino
LA STAMPA: SPECCHIO DEI TEMPI.
Un lettore ci scrive:
“Concordo pienamente con quanto detto dal signor Carlo Pagliero e pubblicato da
Specchio dei tempi a proposito della
sciagura di Verrua. Anch’io, questa primavera, ero stato malissimo impressionato
dalla situazione e, appena a Torino, segnalavo la cosa alla Soprintendenza ai
Monumenti, parendomi enorme che per trovare di che fare cemento non ci fosse di
meglio che rovinare la storica Rocca; avevo anche creduto di capire da qualche
colloquio con abitanti della zona, il loro malumore e l’attesa, direi, della
catastrofe. E’ avvenuto dunque quello che doveva avvenire.
L’opinione pubblica vuole sapere e pretende che si vada fino in fondo.
Certamente chi dette il permesso e chi perforò la Rocca non si proponevano di
buttarla giù e di ammazzare la gente, ma ci voleva poco a immaginare che date
certe premesse ne conseguissero certi risultati. Ora stiamo a vedere che cosa
capiterà alla Sacra di San Michele; c’è solo da sperare che quando il monumento
verrà giù, non ci sia troppa gente in cima”.
Valdo Fusi
presidente dell’EPT di Torino
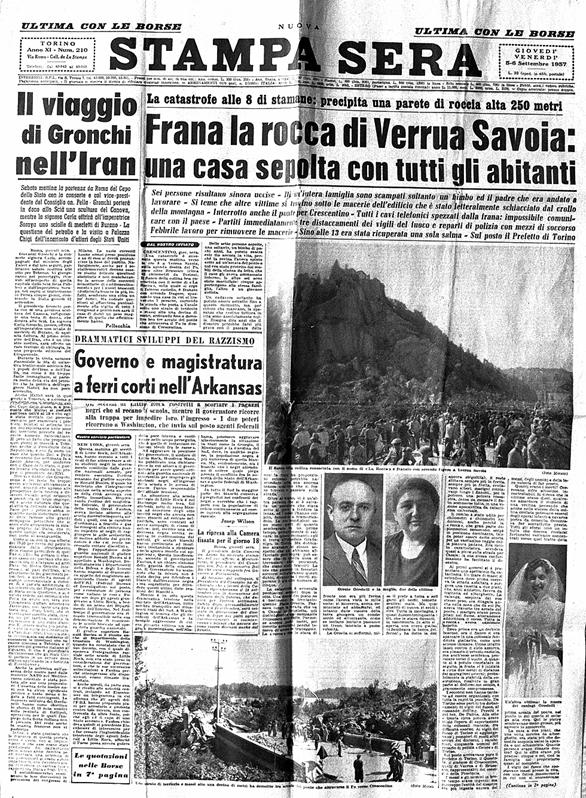
Figura 15 - STAMPA SERA del 5-6
Settembre 1957.

Figura 16 - STAMPA SERA del 6-7
Settembre 1957.
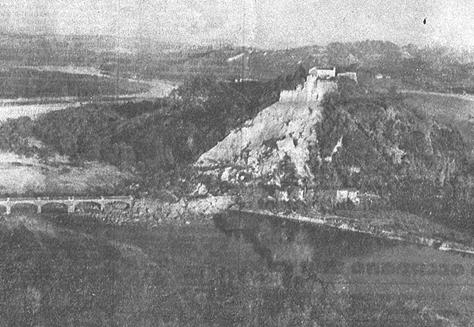
Figura
17 - LA STAMPA del 6 Settembre 1957:
Verrua Savoia vista dall’aereo dopo la frana. L’enorme valanga ha travolto una
casa e parte del ponte sul Po
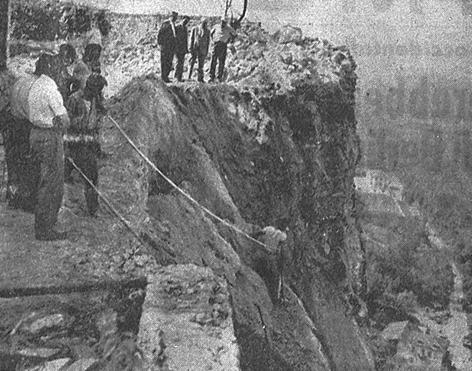
Figura 18 - LA STAMPA del 7 Settembre
1957: Un minatore scende nella voragine della Rocca per posare mine sotto i
massi pericolanti.
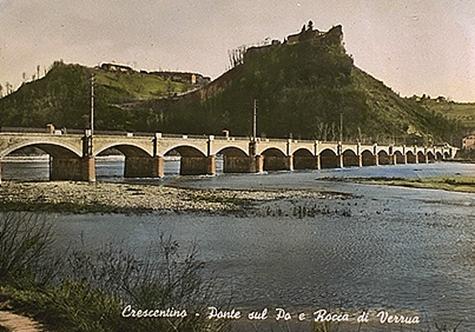
Figura 19 - LA ROCCA PRIMA DELLA CAVA.
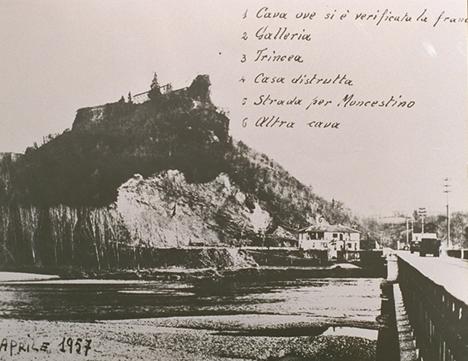
Figura 20 - LA ROCCA PRIMA DELLA FRANA.
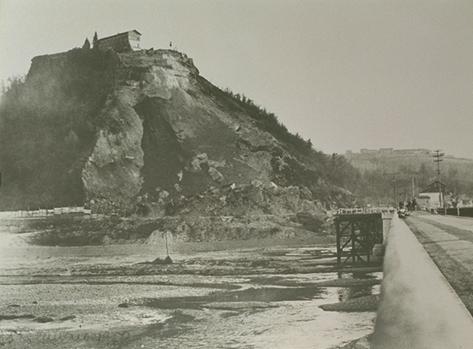
Figura 21 -
LA ROCCA DOPO LA FRANA.
Parte 3
LA ROCCA OGGI
1) CAMMINANDO TRA I RUDERI
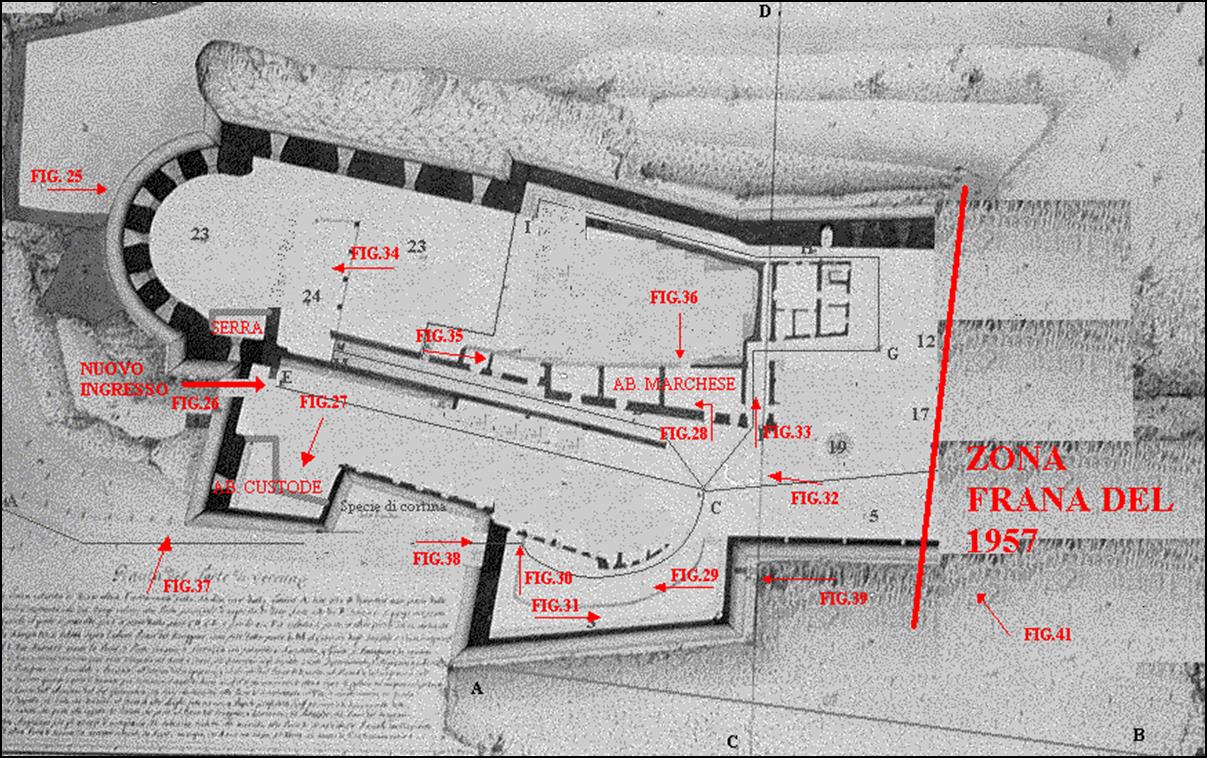
Figura 22 - PLANIMETRIA AGGIORNATA DELLA
FORTEZZA. Si tratta della pianta del
Cantoregio, riportata nella fig.10, modificata. Le frecce rosse indicano
l’inquadratura delle fotografie successive, identificabili dalla corrispondente
numerazione. La strada marcata A B dal Cantoregio serve ora solamente a
costeggiare la fortezza, in quanto è stato eliminato il ponte levatoio e la
relativa rampa di accesso. All’ingresso attuale si arriva con una nuova stradina
in salita, che accede così direttamente al cammino segnato con la linea E C
della planimetria originale. Tutti i fabbricati militari posti ai lati di questa
via sono stati eliminati, mentre una nuova abitazione per il custode risiede
oggi sul bastione, che dava luogo al piazzale 26: tale abitazione viene così a
trovarsi immediatamente alla destra della nuova porta di ingresso. Salendo per
la via C M non si trova più il magazzino per gli attrezzi di artiglieria n. 24,
ma i resti di una serra, sorta probabilmente in seguito alla modifica di detto
magazzino. Completamente eliminato il quartiere dell’ultimo piano, il cui
terrapieno è diventato parte integrante del piazzale del Dongione. Nel crollo
del 1957 sono scomparsi la Chiesa di cui al n. 17, la Rocca marcata con il n. 11
ed una vicina garitta, il piazzale n.8 già privo del magazzino n.7. Il pozzo di
cui al n. 19, ora riempito con i detriti della frana, si trova ora all’esterno
del fabbricato, in quanto sono stati eliminati i muri perimetrali dal locale che
lo conteneva, probabilmente perché adiacenti a quelli della cappella crollata
con la frana.
Arrivando a piedi dalla stradina che conduce alla fortezza, oltrepassata sulla
propria destra la cava di cemento, si giunge ad un bivio: a destra si dirama il
viale (fig.24) che segue quella che era la vecchia via principale di ingresso al
forte all’epoca del Cantoregio, raggiungendo il ponte levatoio oggi non più
esistente, mentre, proseguendo diritto, la strada sale svoltando poi a destra
costeggiando il Dongione (fig.25) fino a raggiungere l’attuale ingresso
principale (fig.26). Superato ciò che resta del portone, immediatamente sulla
destra si trova l’abitazione del custode (fig.27), costruita sul piazzale di cui
al n.26 della planimetria del Cantoregio riportata nella fig.10. Proseguendo
oltre, sulla sinistra si erge il muraglione che sostiene la scala che porta al
Dongione e, subito dopo, l’abitazione del Marchese (fig.32). Dalla prima porta,
situata al piano terreno, è possibile scorgere le cantine (fig.28). Se, invece
di dirigersi a sinistra verso le cantine, si prosegue verso destra, si raggiunge
il passaggio (fig.29) che portava, in uscita, al ponte lavatoio. Sulla destra di
tale passaggio si scorgono le cisterne di raccolta per l’acqua irrigua (fig.30)
mentre, proseguendo sulla sinistra, si imbocca l’ingresso alla porta di soccorso
detta Calcina, ora murata: il passaggio è ancora agibile e, con estrema cautela
e muniti di torce, è possibile giungere a dei locali presumibilmente un tempo
adibiti a prigione. Tornando indietro sul piazzale e salendo dalla scala
visibile in fig. 32, si arriva al piazzale del Dongione (fig.34). Da tale
piazzale, si può vedere ciò che resta all’interno dell’abitazione del Marchese
(fig.35 e 36): sconsigliamo vivamente di entrare nell’immobile, in quanto le
solette ancora esistenti non garantiscono di reggere il peso di una persona.
Ridiscendendo dalla fortezza e prendendo il viale precedentemente citato, si
giunge al primo bastione (fig.37), da dove partiva la rampa di accesso al
vecchio ingresso (fig.38), raggiungibile ai tempi col ponte levatoio. Tale
ingresso si trova sulla parte frontale del secondo bastione, superato il quale
si può vedere, sul suo retro, la sagoma della porta di soccorso detta Calcina
(fig.39). Proseguendo ancora lo stretto sentiero che costeggia la base dei
muraglioni della fortezza, si giunge alla zona della frana del 1957, che
trascinò via con se la rocca ed il piazzale antistante, che sorgeva sulla parete
scoscesa della collina prospiciente la confluenza tra il Po e la Dora.
Volendo, è ancora raggiungibile dall’alto il ponte di soccorso (fig.44): per
fare questo è necessario costeggiare la cava lasciando la stessa sulla destra,
passando su quello che era un vecchio sentiero posto ad un livello inferiore a
quello del viale: il passaggio è tuttavia estremamente difficoltoso, a causa
della folta vegetazione.
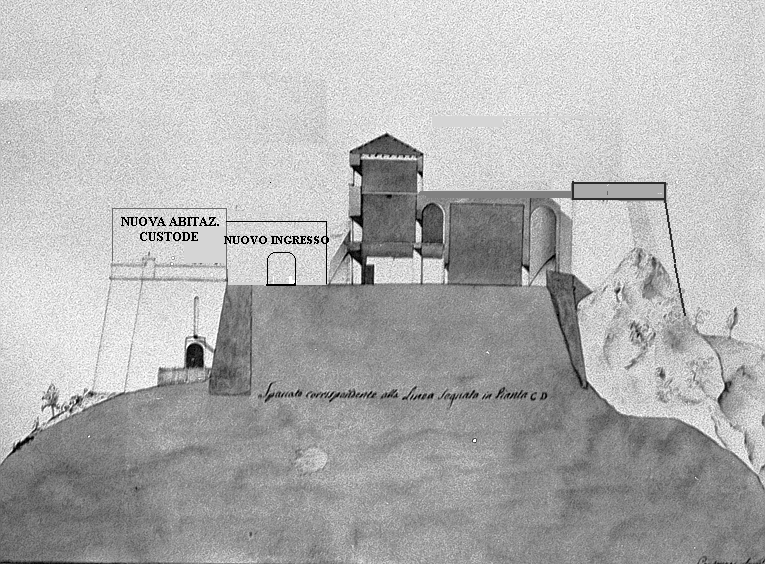
Figura 23 - SEZIONE AGGIORNATA DELLA
FORTEZZA. E’ lo spaccato del
Cantoregio riportato nella fig. 12, opportunamente modificato. Sono stati
eliminati i fabbricati militari dal piano inferiore, al posto dei quali è stato
ampliato il cortile e costruita un’abitazione per il custode, situata nelle
immediate adiacenze della nuova porta di ingresso, che sostituisce il passaggio
del vecchio ponte levatoio. Sul lato destro, non c’è più il quartiere che
costituiva l’ultimo piano, ed è stato così ampliato il piazzale del Dongione,
che ora comunica direttamente con la terrazza che confinava con la Rocca
crollata nel 1957.

Figura 24 -
VIALE E DONGIONE.
Il viale sulla destra costituisce
la vecchia via di accesso all’ingresso dal ponte levatoio.

Figura 25 -
DONGIONE E PORTA DI INGRESSO.
Si noti come la vegetazione stia ormai
minando in maniera preoccupante l’integrità della struttura.

Figura 26 - INGRESSO PRINCIPALE.

Figura 27 - ABITAZIONE
CUSTODE-GIARDINIERE.

Figura 28 - CANTINE.
Situate al livello del piazzale d’ingresso, sotto l’abitazione del Marchese,
erano ancora in uso nel 1955, anno nel quale il castello venne ceduto
all’impresa cementifera.

Figura 29 - PASSAGGIO EX-PONTE LAVATOIO.
Sul fondo l’apertura della vecchia
porta d’ingresso del ponte levatoio, mentre sulla sinistra si scorge il
passaggio che portava alle prigioni ed alla porta di soccorso detta Calcina
(vedi fig. 31). Sulla destra si trovano le cisterne riportate nella fig. 30.

Figura 30 - CISTERNE.
Fungevano da raccolta dell’acqua piovana
ed erano in uso per l’irrigazione agricola fino al 1955.
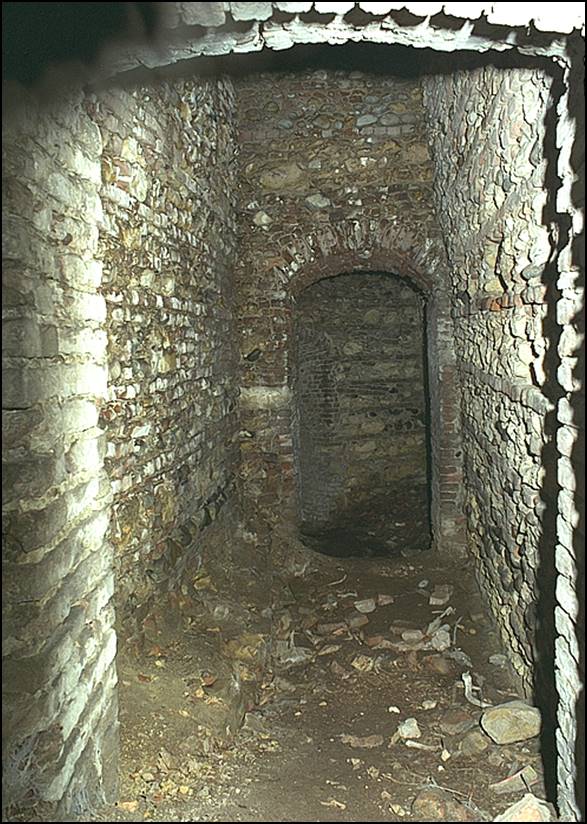
Figura 31 - INGRESSO PASSAGGIO ALLA
PORTA DI SOCCORSO DETTA CALCINA ED ALLE PRIGIONI.

Figura 32 - ABITAZIONE DEL MARCHESE.
Sulla destra: porta ingresso dal piano
inferiore, porta cantine, scala di accesso al Dongione. Sul fondo: abitazione
del custode. Sul piazzale erano costruiti i fabbricati militari lungo la via
marcata E C dal Cantoregio.
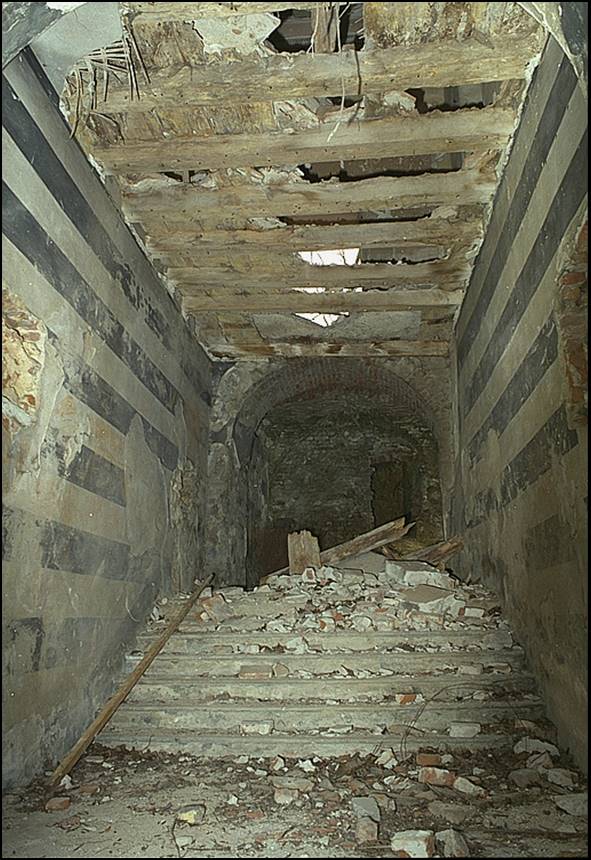
Figura 33 - INGRESSO ABITAZIONE DAL
PIANO INFERIORE.

Figura 34 - SERRA E VEDUTA PARZIALE DEL
PIANO DONGIONE.

Figura 35 - INTERNO ABITAZIONE DEL
MARCHESE. Si noti in alto il
rifacimento delle travi del tetto, in seguito alla convenzione stipulata nel
1989 tra il Comune di Verrua e l’impresa cementifera per il rinnovo della
concessione della cava.

Figura 36 - INTERNO ABITAZIONE DEL
MARCHESE.

Figura 37 - ZONA INGRESSO E DONGIONE.
La foto è stata scattata in fondo al
viale della fig. 24, all’angolo del primo bastione: proseguendo nel sentiero, si
giunge alla “specie di cortina” dove era situata la rampa che conduceva al ponte
levatoio.

Figura 38 - INGRESSO DEL PONTE LEVATOIO.

Figura 39 - PORTA DI SOCCORSO DETTA
CALCINA. Ora murata, se ne intravede
il perimetro tra la folta vegetazione che soffoca e sgretola i muraglioni.

Figura 40 - FERITA NEI MURAGLIONI.
L’immagine riporta uno dei numerosi squarci che rischiano di pregiudicare, se
non saranno prontamente rimarginati, la struttura della fortezza.

Figura 41 - ZONA DELLA FRANA.
Vista dal punto dove cominciarono a
staccarsi i muraglioni che chiudevano la fortezza, tra la piattaforma segnata
con il n. 8 dal Cantoregio e la Rocca. In alto si intravede quella che fu
l’abitazione del Marchese.

Figura 42 - CAVA DI CEMENTO.
Fotografata nei pressi del viale, con la
schiena rivolta al castello.

Figura 43 - CAVA DI CEMENTO.
Dal lato opposto al castello, visibile
sullo sfondo.

Figura 44 - PONTE DI SOCCORSO.
Ormai allo stremo, è visibile dalla
strada che conduce a Gabiano. Era normalmente usato fino al 1955 per scendere a
piedi dal castello, per una via ben visibile nella fig. 19, al ponte sul Po.
2) LA CONVENZIONE DEL 1989
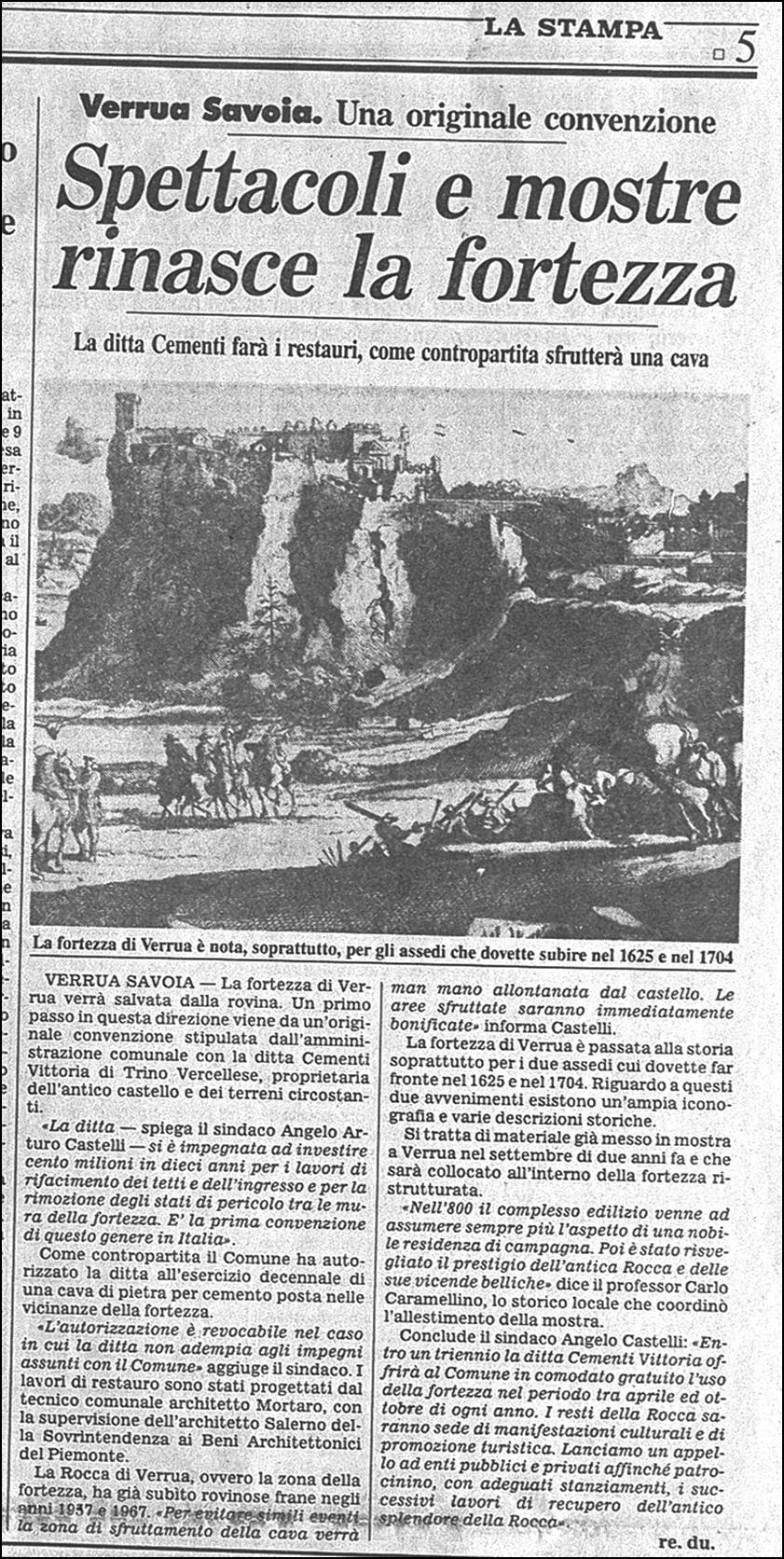
Figura 45 - LA STAMPA del
18 Febbraio 1989.
La fortezza di Verrua verrà salvata
dalla rovina. Un primo passo in questa direzione viene da un’originale
convenzione stipulata dall’amministrazione comunale con la ditta Cementi
Vittoria di Trino Vercellese, proprietaria dell’antico castello e dei terreni
circostanti.
“La ditta - spiega il sindaco Angelo Arturo Castelli, -
Si è impegnata ad investire cento milioni
in dieci anni per i lavori di rifacimento dei tetti e dell’ingresso e per la
rimozione degli stati di pericolo tra le mura della fortezza. E’ la prima
convenzione di questo genere in Italia”.
Come contropartita il Comune ha
autorizzato la ditta all’esercizio decennale di una cava di pietra per cemento
posta nelle vicinanze della fortezza.
“L’autorizzazione è revocabile nel caso in cui la ditta non adempia agli impegni
assunti con il Comune” aggiunge il sindaco. I lavori di restauro sono stati
progettati dal tecnico comunale architetto Mortaro, con la supervisione
dell’architetto Salerno della Sovrintendenza ai Beni Architettonici del
Piemonte.
La Rocca di Verrua, ovvero la zona della
fortezza, ha già subito rovinose frane nel 1957 e 1967.
“Per evitare simili eventi la zona di
sfruttamento della cava verrà man mano allontanata dal castello. Le aree
sfruttate saranno immediatamente bonificate” informa Castelli.
La fortezza di Verrua è passata alla
storia soprattutto per i due assedi cui dovette far fronte nel 1625 e nel 1704.
Riguardo a questi due avvenimenti esistono un’ampia iconografia e varie
descrizioni storiche.
Si tratta di materiale già messo in
mostra a Verrua nel settembre di due anni fa e che sarà collocato all’interno
della fortezza ristrutturata.
“Nell’800 il complesso edilizio venne ad assumere sempre più l’aspetto di una
nobile residenza di campagna. Poi è stato risvegliato il prestigio dell’antica
Rocca e delle sue vicende belliche” dice il professor Carlo Caramellino, lo
storico locale che coordinò l’allestimento della mostra.
Conclude il sindaco Angelo Castelli:
“Entro un triennio la ditta Cementi
Vittoria offrirà al Comune in comodato gratuito l’uso della fortezza nel periodo
tra aprile ed ottobre di ogni anno. I resti della Rocca saranno sede di
manifestazioni culturali e di promozione turistica. Lanciamo un appello ad enti
pubblici e privati affinché patrocinino, con adeguati stanziamenti, i successivi
lavori di recupero dell’antico splendore della Rocca”.
Parte 4
LA COLLINA DELLA FORTEZZA
UN SITO DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
Nella zona della fortezza e della circostante collina erano presenti numerose
gallerie e stanze sotterranee: in buona parte sono state distrutte dalla cava.
Alcune delle costruzioni superstiti sono però state recentemente riscoperte da
alcuni studenti di architettura di Verrua che, dopo molti anni di oblio da parte
dell’amministrazione comunale e della gente del luogo, stanno ora riscoprendo il
fascino dell’antico maniero.
In prossimità del ponte di soccorso, si favoleggia esistesse l’ingresso di una
galleria che, passando sotto il Po, raggiungeva Crescentino, per permettere agli
assediati della Rocca di rifornirsi di provviste: resta il fatto che la parte
incontaminata della collina costituisce una vera e propria miniera di gallerie e
fondamenta delle vecchie costruzioni. Nella zona della cava, infine, sono
possibili ritrovamenti di fossili relativi a flora e fauna marina.
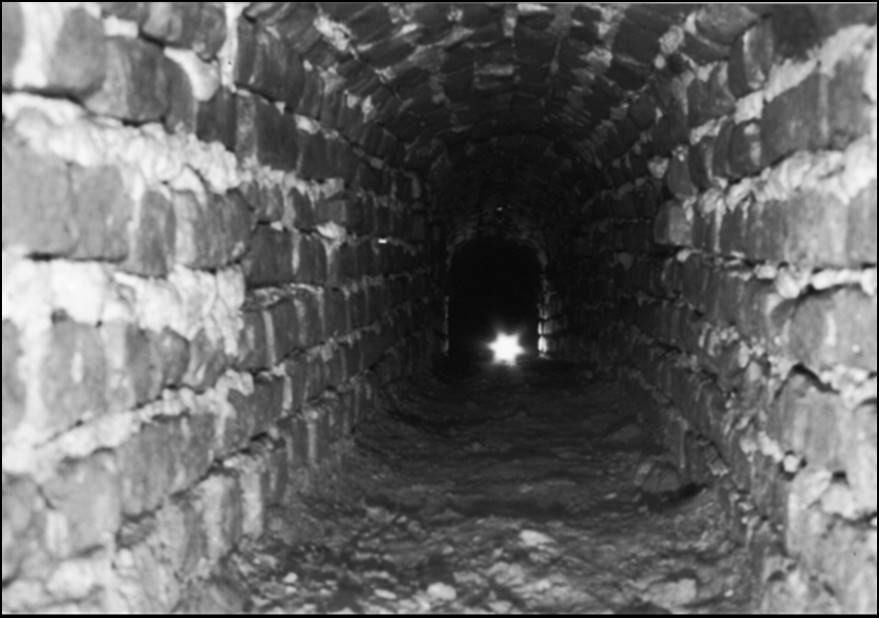
Figura 46 -
GALLERIA CONTROMINA.
Posta a circa 250 metri dal Dongione, alcuni metri sotto la vecchia vigna sul
lato della frazione Faldella. Lunga circa 40 m, le misure approssimate sono di
cm 60 x 60. Foto: Massimo Ottino.
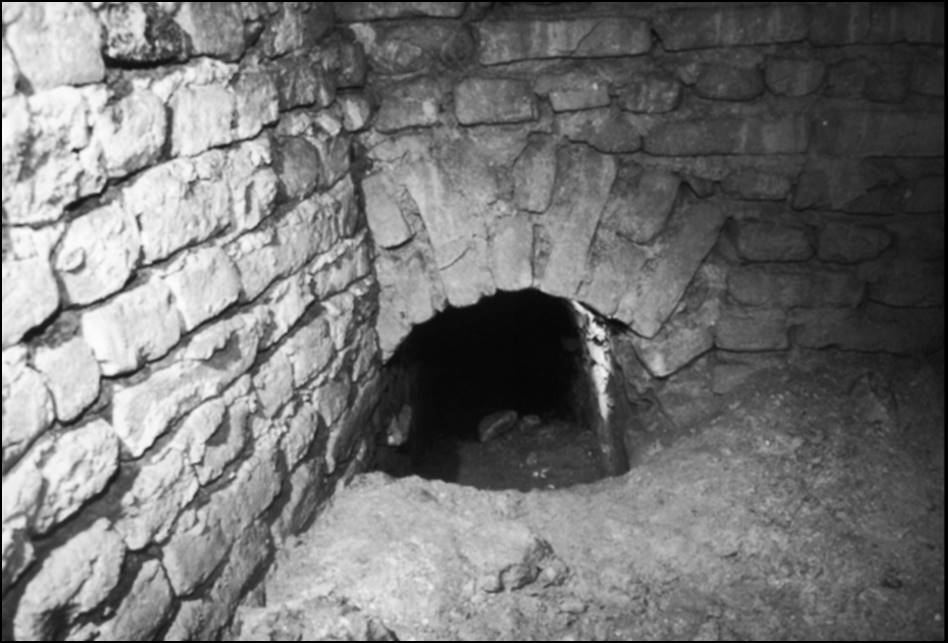
Figura 47 -
FINE GALLERIA CONTROMINA.
Foto: Massimo Ottino

Figura 48 - POZZO.
Si trova a circa 30 m prima del viale
della fig. 24. Foto: Massimo Ottino.
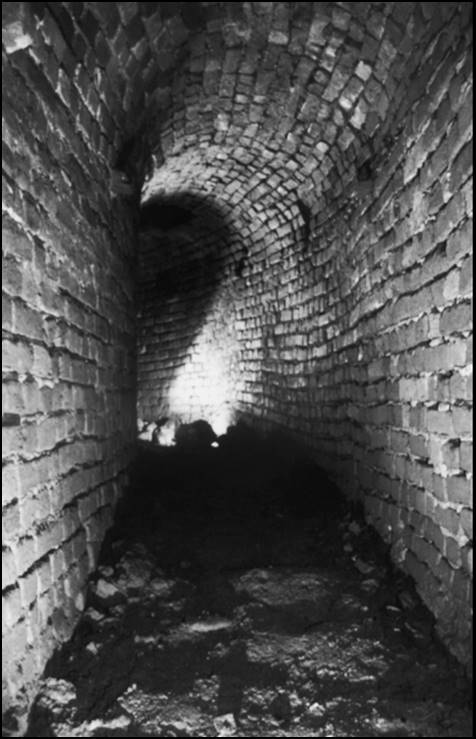
Figura 49 -
GALLERIA.
Posta nelle immediate vicinanze del pozzo
di cui alla fig. precedente, misura m 2,5 x 1. Lunga circa m 30, è erosa da
entrambi i lati dalla cava. Foto: Massimo Ottino
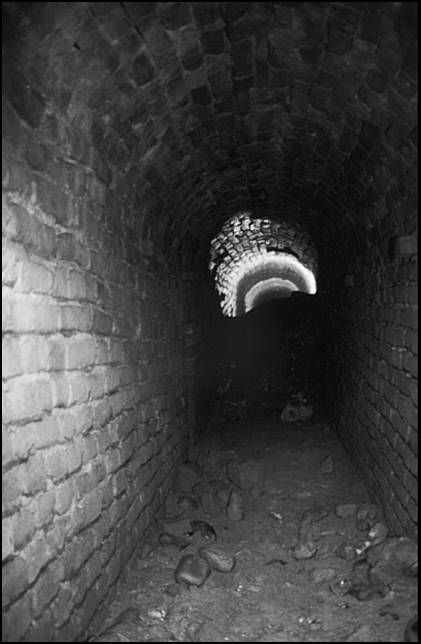
Figura 50 - GALLERIA.
Altra ripresa della galleria di cui alla
fig. 49. Foto: Massimo Ottino.
Parte 5
M
LE RIPRESE DI "GUERRA E PACE" DEL 1955
Nel 1955, nella parte interessata dalla frana del 1957, venne girata una breve scena del film "Guerra e Pace": https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_e_pace_(film_1956)
 a
a
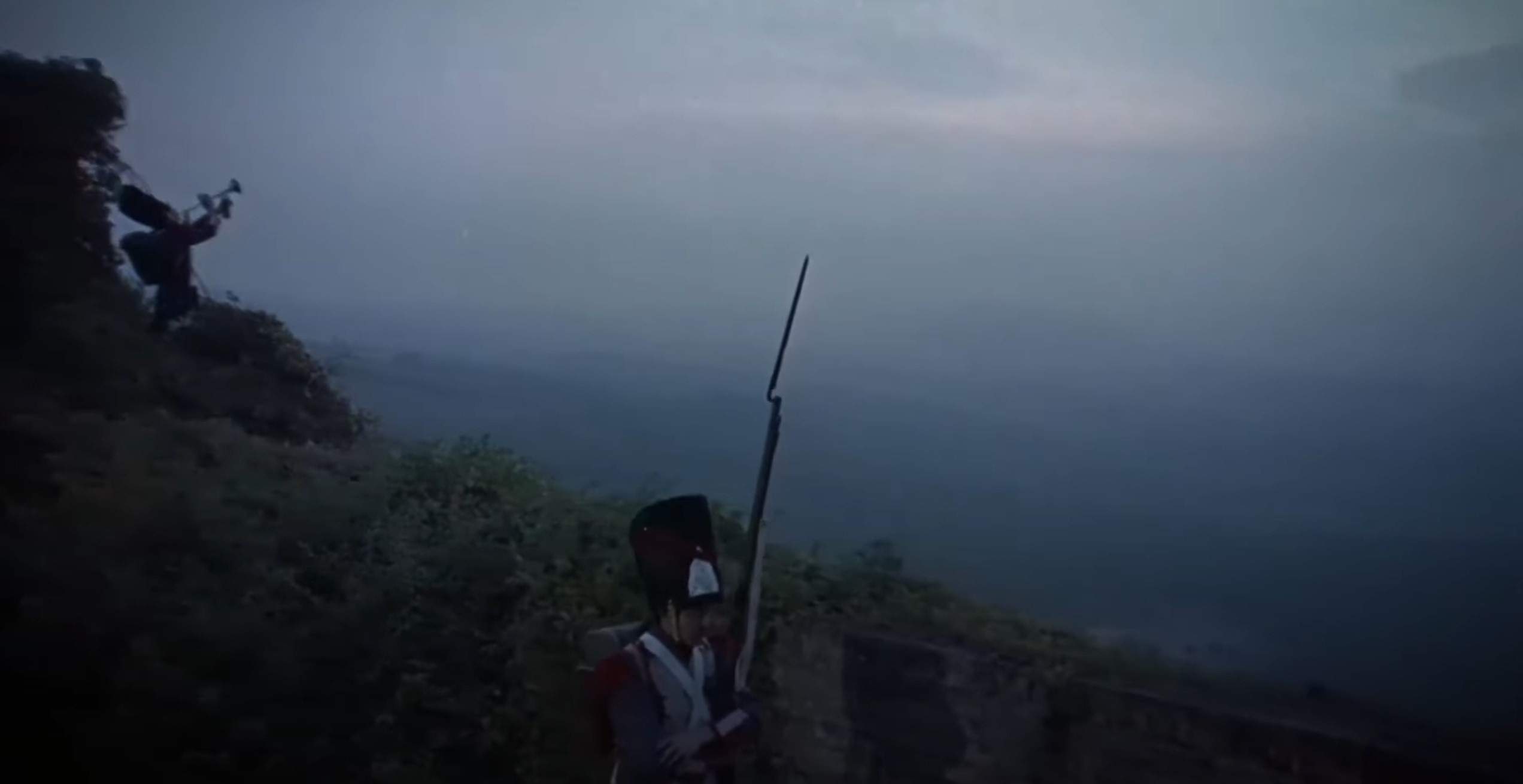 a
a
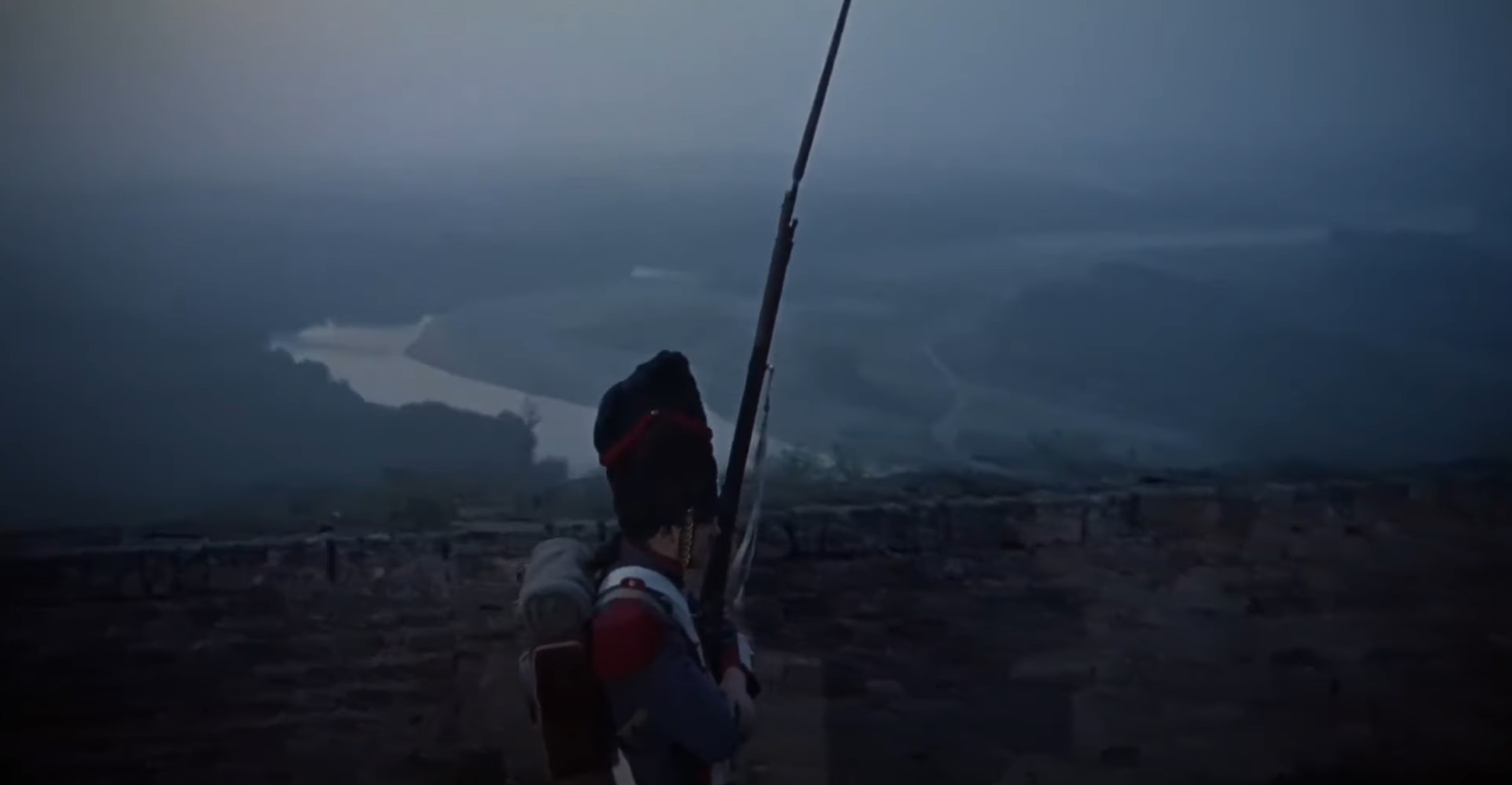 a
a
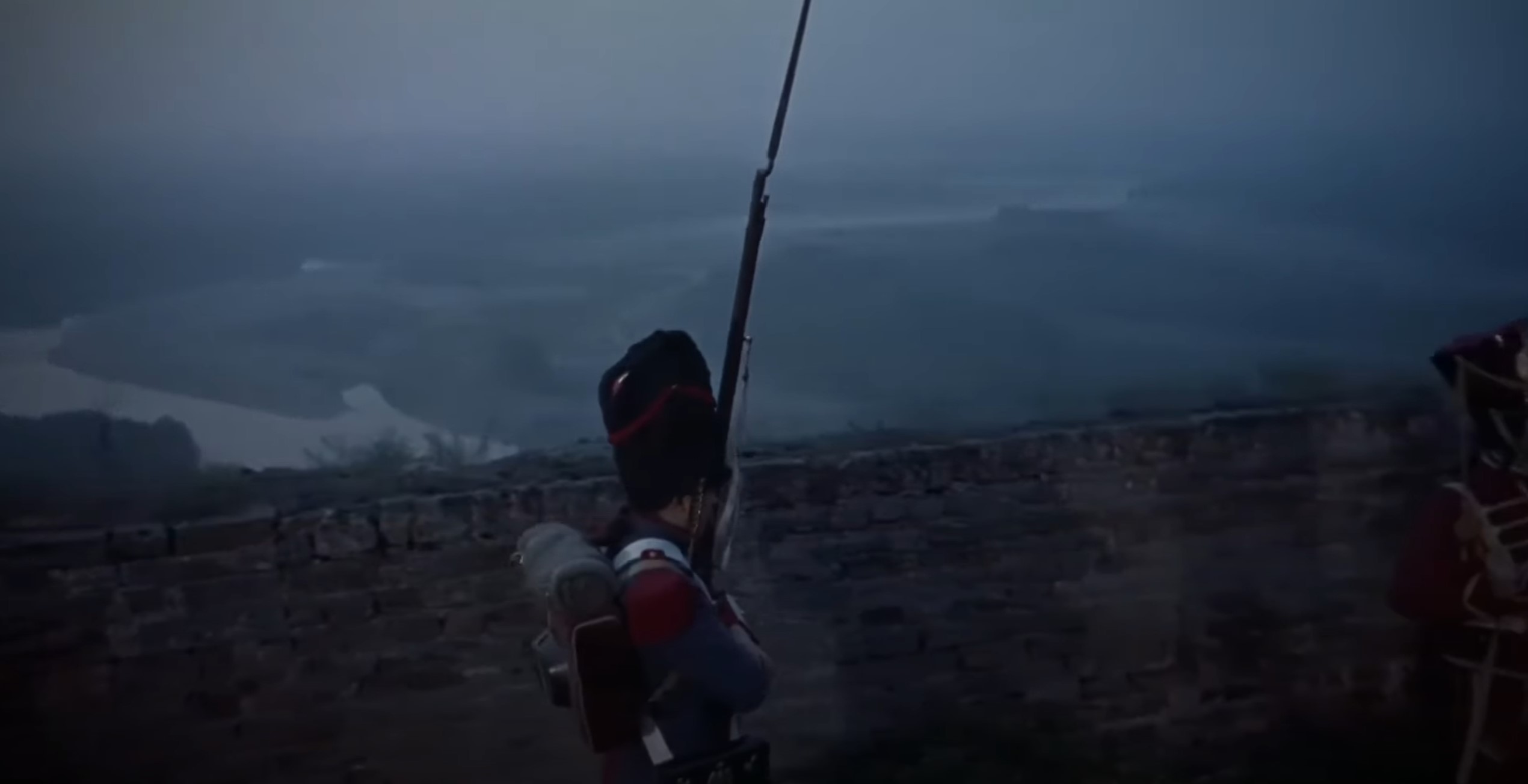
 a
a
 a
a
bibliograFIA
Comune di Verrua Savoia. Verrua Savoia:
immagini di una fortezza. Verrua Savoia: 1987.